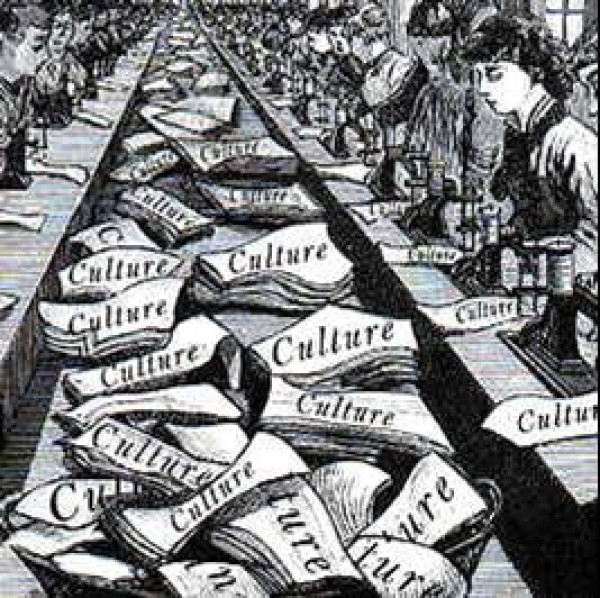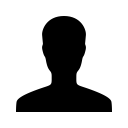Un rapporto definisce l’industria della cultura
- Scritto da Segreteria Assomusica
- Pubblicato in Attualità
24 Luglio 2013 - C’è qualcosa, nel panorama produttivo italiano, in grado di far riemergere l’Italia.
E’ immateriale, non delocalizzabile, capillare e creativo.
E’ in grado di competere con tutti i prodotti delle economie emergenti senza sfidarli direttamente, semplicemente perché rappresenta la valorizzazione della straordinaria unicità del nostro paese.
Cos’è? La cultura.
Termine vago che può indicare mille cose. Se legato però agli aspetti produttivi ecco che prende forma e si concretizza in una marea d’opportunità. La capacità di caratterizzare con la bellezza tutti una serie di oggetti realizzati dagli artigiani del XXI secolo, l’abilità nel riscoprire le peculiarità architettoniche, artistiche ed enogastronomiche rappresentano tutte possibili materializzazioni dell’abilità del “saper fare”. Una cultura più dinamica e vitale, non legata esclusivamente alle realtà museali: un’esposizione permanente intrisa di passato e condita di futuro.Tutto questo è emerso nel rapporto 2013 “Io sono cultura – L’Italia della qualità e della bellezza sfida la crisi”, realizzato da Unioncamere (Camere di Commercio d’Italia) e da Symbola- Fondazione per le qualità italiane) con la partnership della regione Marche.I numeri parlano chiaro: le imprese impegnate nella cultura, secondo i dati del 2012, sono 460.000 (il 7,5 % delle attività economiche nazionali). Aziende che generano 75,5 miliardi di valore aggiunto (il 5,4 % del totale) e che impiegano il 5,7% degli occupati del paese (1,5 milioni di persone). E’ anche un’importante risorsa anticiclica: il valore aggiunto della cultura anche in questo periodo di crisi non solo ha resistito ma ha guadagnato terreno. In quest’edizione del rapporto è stata messa in evidenza anche la “capacità moltiplicativa” del sistema produttivo culturale, misurando l’effetto traino su altre aree dell’economia. Il “moltiplicatore” è pari a 1,7: per ogni euro di valore aggiunto ne attiva – nel commercio, nel turismo, nei trasporti (ma anche nell’edilizia e nell’agricoltura) altri 1,7. In numeri: 80,8 miliardi di valore aggiunto (tenuto anche in considerazione anche dei 5,8 della pubblica amministrazione e del settore non profit) ne attivano altri 133. Tra “diretto” e “indotto” si arriva a 214,2 miliardi, il 15,3 % dell’economia nazionale. Le potenzialità del sistema culturale italiano si possono esprimere in molti modi, anche attraverso strade finora poco esplorate da designer, piccoli artigiani, creativi e industrie, artisti e stilisti, makers “smanettoni” e contadini. Soggetti che rappresentano il lievito del saper fare italiano e della capacità irripetibile di incorporare nei nostri prodotti la bellezza che “respiriamo”. Ecco qualche spunto emerso dalla lettura dell’approfondito lavoro di ricerca.
DESIGN
Il design è la disciplina trasversale che dà forma al mondo. Qual è il suo ruolo nel sistema dell’economia culturale in Italia? Da quando evidenzia il rapporto emerge il ruolo guida delle aziende “Design Driven” in Italia, caratterizzate dall’innovazione e dal dinamismo. Sono organizzazioni che operano nel campo della moda, del design, dell’artigianato e del gusto. Il loro fatturato oscilla intorno al 5% del PIL nazionale, una percentuale apparentemente modesta che però in termini di ricaduta d’immagine sul nostro paese assume un valore esponenziale e trainante difficilmente quantificabile. Una realtà che però si scontra con la grande frammentazione del sistema produttivo, caratterizzato da piccole imprese. Emerge chiaramente una tendenza, quella del design “autoprodotto”: designer-artigiani che producono direttamente senza ricorrere a imprese. Oppure aziende-design in grado di mettere in collegamento i designer con i clienti senza però occuparsi della produzione.
I TIPI D’IMPRESA E LA LORO LOCALIZZAZIONE IN ITALIA
Lo studio ha permesso di evidenziare quelle che sono le relazioni tra cultura ed economia, avvenuta identificando 4 aree di produzione: industrie culturali (come la cinematografia, la televisione, l’editoria e l’industria musicale); industrie creative (tra le quali le aziende export oriented che puntano sul design e sullo stile per essere competitive sui mercati internazionali); organizzazioni che lavorano per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico architettonico (che lavorano per la sua conservazione, fruizione e utilizzo economico); performing arts e arti visive (le attività che, per la loro natura, non si prestano ad un modello di organizzazione di tipo industriale).Analizzando il contributo della “imprenditoria culturale” in ogni macro-ripartizione e regione, emerge il ruolo del Nord-Ovest e del Centro Italia (rispettivamente 8,4 e 8,3% del totale imprese). Nel dettaglio, la Lombardia risulta in testa alla graduatoria per incidenza delle imprese culturali (le 88mila imprese rappresentano il 9,2% dello stock complessivo regionale), seguita dal Lazio, dove le quasi 54 mila unità individuate corrispondono a una incidenza dell’8,7%. La prima provincia per presenza di industrie culturali sul totale delle attività economiche è Firenze.
START-UP E DINTORNI
Un ulteriore parte dettagliata è dedicata a due problemi molto sentiti: la capacità dell’azienda di strutturarsi per affrontare i mercati e lo sviluppo dell’impresa nelle fase iniziali. Limiti che non permettono a molte realtà di “sfondare” nei mercati più promettenti. Le soluzioni? L’assistenza di manager capaci, le reti d’impresa e il cooworking. Accanto all’impresa che crea utili c’è però anche quella no-profit, con tutte le problematiche che riguardano soprattutto la raccolta dei fondi.
FORMAZIONE
Attenta anche l’analisi della formazione delle persone che lavorano in questo settore. Il rapporto evidenzia uno “scollamento” tra la formazione e le realtà operative. Le professionalità che il mondo culturale richiede sono diverse e si devono occupare di una complessità multidisciplinare nella quale gli aspetti di marketing, gestionali e giuridici non sono indifferenti.
EUROPA
Il rapporto ha anche analizzato quelle che sono le interazioni tra l’Europa e la cultura, evidenziandone l’atteggiamento riguardante l’importanza stratetica di questo settore e i meccanismi di erogazione dei fondi a sostegno delle aziende che operano in questo campo.
ESEMPI POSITIVI
Tra le aziende citate come esempio positivo c’è Eataly, la creazione di Oscar Farinetti dedicata al cibo d’alta qualità. Un’azienda che si è basata sulla filosofia “slow food” sviluppata da Carlo Petrini. Validissimo esempio di come sia possibile sviluppare il sistema “di nicchia” del cibo senza perdere di vista la qualità. Altro esempio è Arduino, piattaforma hardware e “open” sviluppato in Italia da Massimo Banzi.
SALONE E FUORISALONE
Cambiano anche le modalità espositive. Un esempio classico è quello del “fuorisalone” di Milano. Sviluppatosi come alternativa più cittadina rispetto al salone del mobile, quest’evento ha saputo nel tempo ritagliarsi una sua identità ben precisa. Se il salone classico è uno spazio formale e “serio” il suo antagonista cittadino offre spazio alla creatività, dando modo alle imprese e ai designer di esplorare nuovi campi con più coraggio.
FOCUS: L’INDUSTRIA CULTURALE MARCHIGIANA
La Regione Marche è stata oggetto di una ricerca più approfondita. Dai dati emerge l’elevato numero delle industrie creative (rappresentano il 75% del totale). Tra esse ha una grande importanza l’artigianato: su 9.885 imprese ben 4.231 operano in questo campo. Pesano e Urbino sono i grandi “poli”, con una notevole concentrazione di imprese creative. Le realtà imprenditoriali legate alla cultura hanno anche la peculiarità di essere più giovani e a maggiore presenza femminile rispetto alla media nazionale. Notevole è inoltre la propensione degli imprenditori marchigiani a “fare rete”. Un aspetto che deve far riflettere circa il livello strategico della cultura per lo sviluppo della regione marchigiana è il suo stretto legame con l’attrattività turistica dell’area.Le Marche sono la prima regione in Italia per quota di spesa turistica attivata dalla componente culturale.
PER SAPERNE DI PIU’
Per leggere tutto l’interessante e corposo rapporto si può visitare il sito www.unioncamere.gov.it, nella sezione “primo piano”. Sono 213 le pagine ricche anche di tabelle e dati che aiutano a comprendere le potenzialità dell’uso produttivo della cultura in Italia.
Fonte: www.lastampa.it
Ultimi da Segreteria Assomusica
- ASSOMUSICA PROSEGUONO LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE A SOSTEGNO DELLA MUSICA LIVE
- DOLORE E CORDOGLIO PER L’IMPROVVISA SCOMPARSA DEL PRESIDENTE VINCENZO SPERA
- Stati Generali della Musica: Assomusica, Afi, Fem, Fimi, Nuovo Imaie, Pmi e Siae consegnano un documento al sottosegretario al Ministero della Cultura Gianmarco Mazzi
- L’APPELLO DI ASSOMUSICA SULLA 18app: NON SI BUTTI AL VENTO UN ISTITUTO CHE FUNZIONA
- Assomusica alla Milano Music Week: CODICE DELLO SPETTACOLO PRIORITÀ, EMERGENZE ED ESIGENZE DEL SETTORE DEL LIVE MUSIC